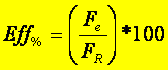Trasmissione:
L’idea di costruire una bicicletta interamente in plastica, ha richiesto una revisione del sistema trasmissione, soprattutto perché è improbabile pensare di riprodurre fedelmente gli stessi componenti modificando solamente quello di cui sono fatti. La soluzione a cui si è giunti è stata la progettazione di un sistema meccanico costituito da due pulegge dentate al posto delle corone e da una cinghia, anch’essa dentata, che sostituisse la catena. Il tutto fissato sul telaio allo stesso modo di una bicicletta classica. Requisito importante, insieme all’utilizzo di materie plastiche riciclabili, è stato quello di cercare di ridurre i costi di produzione e sviluppo.
Questo ha portato ad avvallare la soluzione a rapporto fisso (più economica) e ad eliminare le eventuali prospettive di pulegge CVT (molto più costose e sofisticate) a rapporti variabili di velocità (vedi i variatori dei motocicli), le quali si servono di pulegge costituite da due semi-pulegge tronco-coniche, una delle quali potendo scorrere assialmente rispetto all’altra consente di variare il raggio di avvolgimento della cinghia e quindi il rapporto di trasmissione (vedi figura).
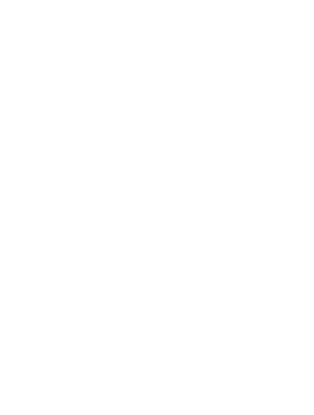
Nei C.V.T. a pulegge espandibili su ciascuna semi-puleggia mobile viene esercitata, mediante apposite apparecchiature, la forza assiale necessaria ad equilibrare la spinta della cinghia. Generalmente questo tipo di trasmissioni continue sono a cinghie trapezoidali: sulla semi-puleggia mobile condotta agisce una molla, mentre l'apparecchiatura di regolazione, ad esempio di tipo oleodinamico, agendo sulla semi-puleggia mobile motrice, impone il rapporto di trasmissione desiderato. In tali casi è necessario un sistema di controllo che indichi il desiderato rapporto di trasmissione nelle diverse condizioni di funzionamento.
Vantaggi-Svantaggi rispetto al caso classico
La scelta della cinghia ha introdotto numerosi vantaggi rispetto al sistema a catena:
- silenziosità
- assenza di lubrificazione
- ridotta manutenzione
- costi non elevati.
D’altro canto non sono mancati i problemi; l’inconveniente a cui si è dovuto subito far fronte, per esempio, è stato l’aumento di volume sia per la cinghia che per la puleggia, rispetto alla struttura esile e fine della catena e della corona (una catena attuale è larga soltanto 6mm), che ha richiesto anche un’analisi del telaio. La cinghia, inoltre, al contrario della catena, non può essere aperta per consentirne il montaggio, ma, mantenendo sempre la sua forma ad anello chiuso, necessità di un telaio particolare, comunque differente da quelli usuali, soprattutto nel lato trasmissione (per esempio un monobraccio posteriore simile a quelli motociclistici).
Fasi di progettazione
Dimensionamento di massima
Realizzazione dei pezzi con i supporti informatici a disposizione
Assemblaggio dei pezzi
Verifica statica
Verifica a fatica
Analisi della potenza
La prima fase a cui abbiamo dovuto dedicarci è stata la valutazione delle forze che fanno parte del sistema bicicletta, inteso come sistema in movimento.
Dal calcolo della potenza resistente, termine che comprende la resistenza aerodinamica, l’attrito volvente delle ruote, nonché il peso stesso del veicolo (bicicletta + ciclista + indumenti) quando si è nelle situazioni di superare, per esempio, una salita improvvisa, siamo giunti alla forza che il ciclista deve esercitare sul pedale; tutto in funzione della velocità di traslazione orizzontale.
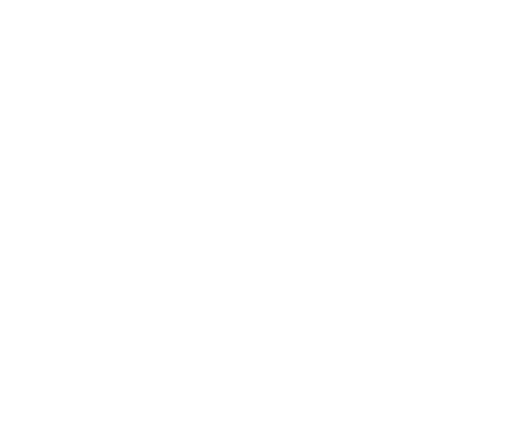
![]()
La potenza resistente, espressa in Watt, divisa per il rendimento del sistema fornisce il valore della potenza motrice (vedi formula), quella che il ciclista deve impiegare per muovere il veicolo,
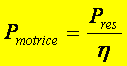 ,
ipotizzando un rendimento globale η pari a 0.6 (termine che comprende gli
attriti in gioco, le dissipazioni di energia, ecc.).
,
ipotizzando un rendimento globale η pari a 0.6 (termine che comprende gli
attriti in gioco, le dissipazioni di energia, ecc.).
Dal calcolo delle potenze si passa facilmente a quantificare quanta forza il ciclista deve esercitare sul pedale, attraverso il momento torcente, applicato al perno del movimento centrale dalla rotazione della pedivella di destra; momento che è legato alla potenza motrice dalla relazione:
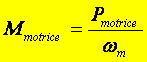 ,
,
dove si indica con ωm la velocità di rotazione della puleggia motrice, cioè quella anteriore.
La velocità angolare omega motore si ricava dopo aver trovato la velocità angolare della ruota posteriore (velocità che coincide con quella della puleggia posteriore, poiché corpi solidali) riscalata del rapporto di trasmissione tra le due pulegge:
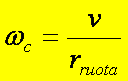 ,
,
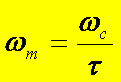 .
.
Forze tra cinghia e puleggia e forza sul pedale
La trasmissione del moto avviene per mezzo della pressione che cinghia e puleggia si scambiano nell’arco di contatto (o angolo di avvolgimento). Tale pressione, entro il limite di scorrimento, impedisce lo scorrimento dei due componenti. Per ottenere la pressione di contatto necessaria alla trasmissione della potenza è necessario porre in tensione la cinghia dando un tiro iniziale S. Così facendo su entrambi i tratti della cinghia vengono esercitate le reazioni T0, pari a S/2. Quando, però si applica il momento Mmotrice all’albero, per il rispetto dell’equilibrio, un ramo della cinghia risulterà teso da un tiro T maggiore di T0, mentre l’altro ramo (ramo condotto) sarà sollecitato da un tiro t minore del tiro statico T0.
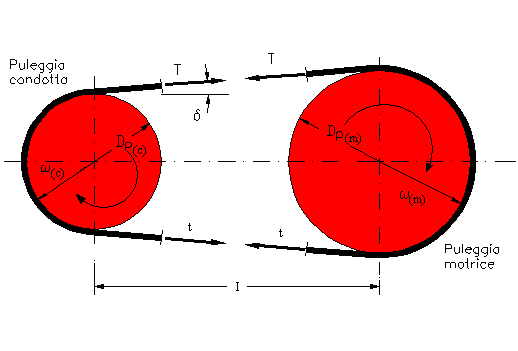
Per cinghie poste in tensione per effetto del peso proprio o per deformazione valgono le seguenti relazioni:
|
T/t |
T |
t |
S |
|
1.5÷2 |
2÷3 P |
1÷2 P |
3÷5 P |
dove la forza P, indica la forza risultante tra tratto teso e compresso.
Arrivando al pedale, bisogna chiarire il fatto che la forza agente su di esso non è costante durante la rotazione della pedivella attorno al perno. Considerando la rotazione in termini angolari, il ciclista divide la forza esercitata sul pedale in due fasi ben distinte: una fase di spinta, compresa tra 0° e 180°, ed una di richiamo tra 180° e 360°. La forza applicata varia annullandosi quando la pedivella si trova a 0° o multipli di 180° di esso (punti morti superiore ed inferiore), e raggiunge il suo valore massimo per un angolo pari a circa 110°.
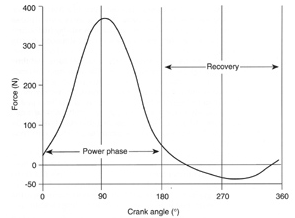
Il momento torcente che si esercita sul perno è dovuto alla componente normale della forza sul pedale lungo la pedivella, così come indicato in figura.
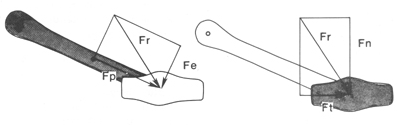
Per rendere possibile la rotazione della pedivella attorno al perno, anche al pedale è concesso di ruotare sul suo perno di aggancio alla pedivella. Per questo motivo, ad ogni angolo di pedivella, il pedale occuperà posizione angolari diverse rispetto alla pedivella stessa.
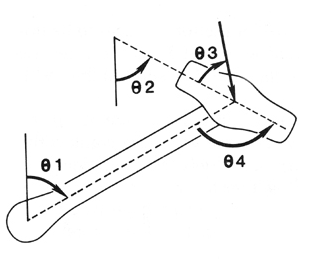
La sua disposizione è ben visibile nell’immagine seguente:
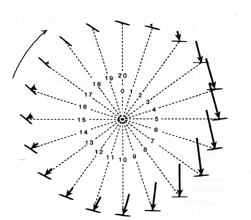
Partendo, quindi, dalla forza Fe, quella che interviene nella formula del momento torcente, si ricavano, attraverso relazioni seno-coseno, tutte le altre forze.
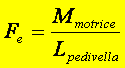 ,
,
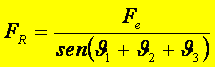 ,
,
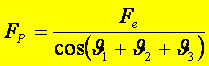 ,
,
![]() ,
,
![]() .
.
Per concludere, è utile introdurre un parametro, che è l’efficienza della pedalata, che esprime, in percentuale, l’effetto del movimento rotatorio e delle forze applicate, rispetto alla pedalata ideale: